|
"BSC" - Associazione per Bologna: SANITÀ & CONOSCENZA O.D.V.
|
|
||
|
|
||
L'ARTE DI VIVERE a cura di: 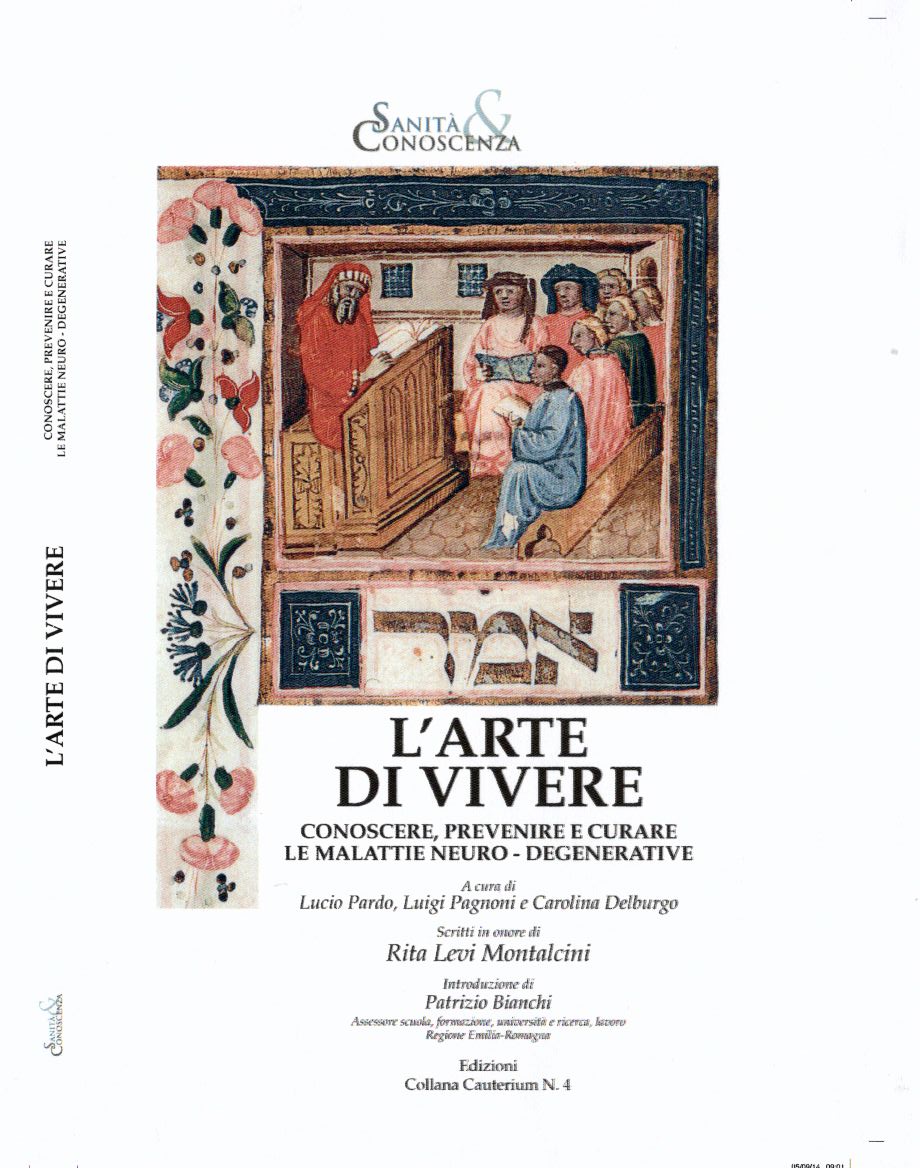 • Locandine
• Abstract • Giornali
INVITO AL CONVEGNO in onore del 103° compleanno di RITA LEVI MONTALCINI  CRESCERE, CONOSCERE, PREVENIRE: dal laboratorio alla prevenzione delle malattie neuro-degenerative AULA POLIVALENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE V.LE A. MORO 50, BOLOGNA LUNEDI 23 APRILE 2012, ORE 14,15

ABSTRACT 1. Prof. P. Calissano RITA LEVI MONTALCINI ED UN FORMIDABILE TRIO. 2. Prof. L. Calzà N. G. F. LO STATO DELL'ARTE NERVE GROWTH FACTOR: LO STATO DELL'ARTE Nel 1986 il premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia viene attribuito a Stanley Cohen e Rita Levi Montalcini "for their discoveries of growth factors". In particolare il riconoscimento premia il lavoro degli anni '50 di Rita Levi Montalcini che portarono alla scoperta del Nerve Growth Factor (NGF). Come si legge nelle motivazioni del premio, si tratta di: 3. Prof. R. Bartesaghi. È POSSIBILE RIPRISTINARE LO SVILUPPO CEREBRALE NELLA La sindrome di Down (SD) è una patologia genetica causata dalla triplicazione del cromosoma 21. I soggetti con SD sono caratterizzati, oltre che da vari problemi medici, da un grave ritardo mentale, l'aspetto più invalidante della patologia. I meccanismi alla base del ritardo mentale sono ancora largamente sconosciuti e non ci sono, al momento, terapie appropriate. Per facilitare lo studio dei meccanismi alla base delle anomalie cerebrali nella SD sono stati creati modelli di topo che presentano molte analogie con la patologia umana, Evidenze crescenti in modelli di topo e in individui con SD suggeriscono che un diffuso e grave difetto di neurogenesi sia alla base delle alterazioni dello sviluppo cerebrale e della disabilità mentale. Questo prospetta la possibilità che terapie mirate a ripristinare la neurogenesi siano in grado di correggere i difetti cognitivi della SD. Sulla base di evidenze che i farmaci antidepressivi sono in grado di aumentare la neurogenesi nel cervello normale, abbiamo cercato di stabilire se sia possibile migliorare/ripristinare la neurogenesi nella SD con un farmaco antidepressivo. Abbiamo utilizzato il topo Ts65Dn, un modello di SD che presenta caratteristiche molto simili alla patologia umana. Abbiamo trattato topi Ts65Dn neonati con fluoxetina, un farmaco antidepressivo di largo uso, ed abbiamo esaminato gli effetti del trattamento sulla neurogenesi e sul comportamento. I risultati mostrano che il trattamento con fluoxetina ripristina completamente la neurogenesi in varie regioni cerebrali, incluso l'ippocampo, una regione cerebrale che svolge un ruolo critico nella memoria a lungo termine. L'analisi del comportamento ha mostrato che i topi Ts65Dn, non trattati, presentano gravi difetti di memoria ippocampo-dipendente e che il trattamento determina il completo recupero di questa funzione. I nostri risultati mostrano che un farmaco antidepressivo prescritto ad adulti e perfino ad adolescenti è in grado di ripristinare le alterazioni dello sviluppo cerebrale e l'apprendimento in un modello murino di SD. Questi risultati potrebbero aprire la strada a trials clinici, mirati a stabilire se questo tipo di13 trattamento sia in grado di migliorarne le capacità cognitive nei bambini con SD.
4. Dott. Elisabetta Ciani Ricercatore confermato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna, da anni si dedica allo studio di malattie neurologiche infantili di origine genetica, caratterizzate da un alterato sviluppo del sistema nervoso centrale quali la sindrome di Down e la sindrome di Rett. NUOVE PROSPETTIVE PER LO STUDIO DELLA VARIANTE CDKL5 La sindrome di Rett è una grave patologia neurologica, che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile. La malattia è congenita e si manifesta, in genere, durante il secondo anno di vita. Colpisce circa una persona su 10.000. La sindrome é associata a ritardo nell'acquisizione del linguaggio e della coordinazione motoria e a grave ritardo mentale. Attraverso la ricerca genetica è stato possibile scoprire che molti casi di sindrome di Rett sono causati da mutazioni nel gene MeCP2. Tuttavia, non tutti i pazienti con sindrome di Rett presentano tali mutazioni e recentemente si è scoperto che mutazioni di un altro gene chiamato CDKL5 sono alla base di una variante della sindrome di Rett, caratterizzata da epilessia precoce. CDKL5 sembra partecipare ad alcune funzioni esercitate da MeCP2, il che spiegherebbe, in parte, perché i due geni possono essere responsabili della stessa malattia. Tuttavia, mentre si conoscono diversi aspetti della funzione di MeCP2, quasi nulla si conosce del ruolo di CDKL5 nello sviluppo del sistema nervoso e nell'evoluzione della sindrome di Rett. Per rispondere a questo quesito abbiamo costituito un consorzio di quattro gruppi di ricerca, ognuno con competenze specifiche nel settore delle neuroscienze, con l'obiettivo di identificare le funzioni di CDKL5. In particolare ci proponiamo di identificare, in sistemi cellulari neuronali appropriati, i geni e le proteine che sono regolati da CDKL5 e di generare un modello di topo che presenti gli aspetti fenotipici di questa variante della sindrome di Rett. I risultati ottenuti permetteranno di identificare i geni o le proteine che potranno essere bersaglio di possibili farmaci, mirati a tentare di rallentare o curare la malattia stessa. 5. Dott. Barbara Monti Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale, Facoltà di Scienza MM.FF.NN. dell'Università di Bologna. Nella sua attività di ricerca si occupa principalmente dello studio delle interazioni tra cellule e neuroni nella neuro degenerazione e nella neuro protezione. INTERAZIONI MICROGLIA - NEURONI NELLA La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia dei motoneuroni, che insorge nell'adulto ed è letale. Circa il 10% della SLA è familiare, mentre il restante 90% può essere classificato come malattia sporadica, ma queste forme sono clinicamente indistinguibili. L'eziologia della SLA rimane ad oggi sconosciuta, tuttavia sono stati identificati 13 geni e loci coinvolti nella SLA. Il primo gene identificato come causa di SLA è la Cu/Zn superossido-dismutasi 1 (SOD1), che rappresenta circa il 15% dei casi di SLA familiare (Rosen et al, Nature, 1993, 362, 59). I meccanismi con cui mutazioni in questo enzima presente in tutte le cellule de13terminano la selettiva degenerazione dei motoneuroni, tuttavia, sono ancora sconosciuti. Di recente, è stato proposto un meccanismo "non-cell autonomous", cioè cellule diverse dai neuroni, come le cellule gliali, astrociti e soprattutto microglia, intervengono nella morte dei motoneuroni stessi (Boillée et al, Science 2006, 312, 1389; Neuron 2006, 5122, 39; Ilieva et al, Cell J Biol 2009, 187, 761). Considerando che fisiologicamente la microglia gioca un ruolo neurotrofico e neuroprotettivo essenziale che cambia con l'infiammazione (Polazzi & Monti, Prog Neurobiol 2010, 92, 293), rimane da capire se nella SLA vi sia una perdita di funzione neuroprotettiva e/o un guadagno di tossicità della microglia verso i motoneuroni. In particolare, è essenziale il ruolo del rilascio microgliale di proteine che intervengono sia nella neuroprotezione che nella neurotossicità (Nagai et al, Nat Neurosci 2007, 10, 615). Recentemente, infatti, abbiamo dimostrato che la microglia in condizioni fisiologiche rilascia la SOD-1, che è neuroprotettiva, e che è questo rilascio è ridotto quando la SOD-1 presenta una delle mutazioni legate alla SLA (Polazzi et al., Neurosignals 2012, in stampa). La comprensione delle interazioni microglia-neuroni, con particolare riferimento alle molecole solubili coinvolte in questo dialogo, è fondamentale per capire i meccanismi di neuroprotezione/neurodegenerazione nella SLA, al fine di sviluppare nuove strategie terapeutiche per contrastare questa devastante neuropatologia. 6. Prof. E. Maestrini Associato di Genetica presso il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale. Università di Bologna. LE BASI GENETICHE DELL'AUTISMO Nel 1943 lo psichiatra Leo Kanner utilizzò il termine "autismo" per descrivere un complesso di sintomi presenti in un gruppo di bambini da lui osservati. Questi sintomi sono riassumibili in tre aspetti: a) un'alterata interazione sociale, b) difficoltà di comunicazione verbale e non verbale, c) comportamenti, interessi e attività ristretti, ripetitivi e/o stereotipati. Tali disturbi comportamentali sono riscontrabili fin dall'infanzia e perdurano per tutta la vita, anche se le caratteristiche assumono un'espressività variabile nel tempo. Fino a qualche tempo fa la risposta alla domanda "che cosa causa l'autismo?" sarebbe stata: "non ne abbiamo un'idea?". La ricerca sta cominciando a dare alcune risposte a questo enigma. Sappiamo innanzi tutto che non c'è una causa unica, come non c'e un unico tipo di autismo. 7. Prof. M. Marini Associato di Biologia Applicata presso il Dipartimento di Istologia Embriologia e Biologia Applicata. Da tempo si occupa di stress cellulare , con particolare attenzione allo stress ossidativo e all'apoptosi, e di segnalazione mediata dalle specie radicaliche. Solo di recente ha iniziato a studiare alcune patologie del sistema nervoso. TERAPIA DELL'ATASSIA DI FRIEDREICH Marina Marini¹, Antonella Pini² e collaboratori L'atassia di Friedreich è la più frequente delle atassie ereditarie (è colpita una persona su 30-50000). È causata da una mutazione somatica recessiva che determina un grave deficit di una proteina che svolge un ruolo essenziale nella formazione e nel funzionamento dei mitocondri, le "centraline energetiche" della cellula. La patologia si manifesta in genere nella seconda decade di vita ed è gravemente invalidante, in quanto il paziente perde progressivamente il controllo motorio; molto spesso inoltre sopravvengono diabete e cardiomiopatia. Non è un caso che gli organi più colpiti siano quelli le cui cellule richiedono maggiori quantità di energia e presentano una capacità più ridotta di rigenerarsi. Infatti mitocondri carenti non significano solo scarsità di energia, ma anche stress ossidativo, in grado di portare le cellule a morire per apoptosi. 8. Dott. P. A. Ruffini - Dompè Farmaceutici Milano NGF NELLA TERAPIA DI PATOLOGIE OFTALMOLOGICHE La potenzialità terapeutica di NGF nelle patologie oftalmologiche dipende dall'attività di questa molecola sulle terminazioni nervose del nervo trigemino e del nervo ottico, sulle cellule nervose della retina, sulle cellule epiteliali della cornea e della congiuntiva e sulla ghiandola lacrimale. Infatti, i recettori di NGF sono espressi in tutti questi tessuti. Numerosi modelli sperimentali hanno confermato il ruolo di NGF nel mantenere il corretto funzionamento della superficie anteriore e della camera posteriore dell'occhio, e la sua attività terapeutica in situazioni di patologia sperimentale. 9. Dott. Aurelia Santoro La Dott.ssa Santoro si è laureata in Biotecnologie presso l'Università di Bologna, ha conseguito nel 2006 il dottorato di ricerca in Biopatologia Molecolare presso l'Università della Calabria e, da oltre 10 anni si occupa di biologia molecolare dell'invecchiamento nel laboratorio del Prof. Claudio Franceschi. E' autrice di oltre 20 pubblicazioni scientifiche ed ha partecipato come relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali. Oggi ci presenterà alcuni tra gli studi più importanti del gruppo di ricerca di cui fa parte sui centenari ed il loro stato cognitivo. CENTENARI, STATO COGNITIVO E MALATTIA DI ALZHEIMER L'invecchiamento umano è un processo dinamico che comporta il costante adattamento del corpo, lungo tutto il corso della vita, all'esposizione a danni interni ed esterni. Pertanto, il fenotipo dell'invecchiamento negli esseri umani è molto eterogeneo e può essere descritto come un mosaico complesso risultante dall'interazione di diverse variabili ambientali, stocastiche e genetiche-epigenetiche. Una caratteristica tipica del processo di invecchiamento è lo sviluppo di uno stato infiammatorio cronico, di basso grado, denominato inflammageing (1), questa condizione è critica nell'insorgenza delle maggiori patologie legate all'invecchiamento come l'aterosclerosi, il diabete di tipo 2, e la neurodegenerazione.
|
|
|
|
| A cura di "BSC" - Associazione per Bologna: SANITA' E CONOSCENZA O.D.V. Tutti i diritti riservati |
Ospitato da Aruba Business
|